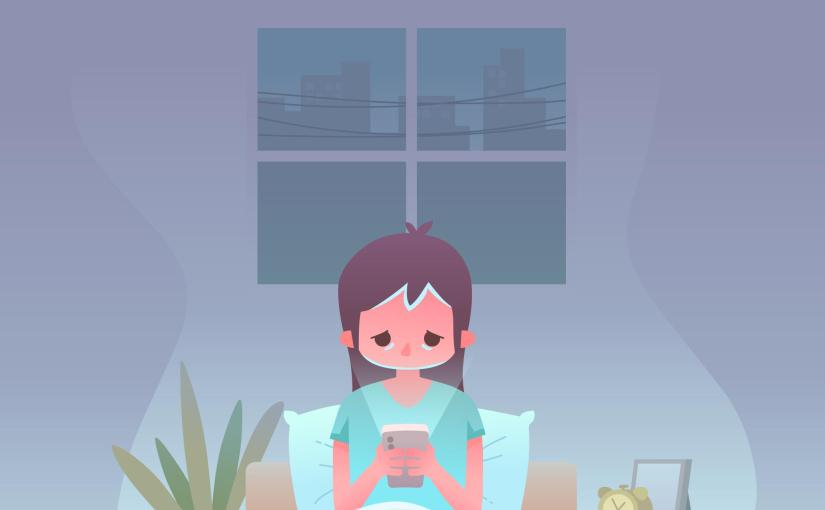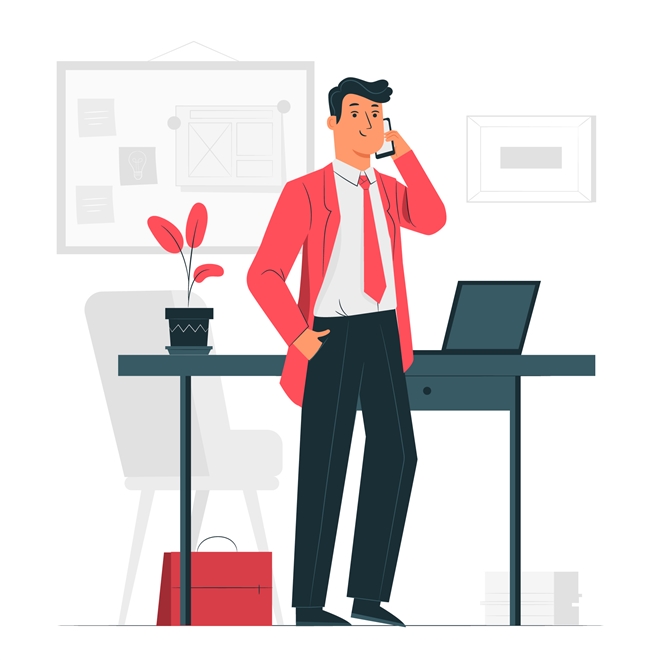Soltanto nell’ultimo mese, leggendo notizie provenienti da varie parti del mondo e ascoltando i commenti e le opinioni al riguardo, si è assistito all’ennesima dimostrazione di come il mondo sia tremendamente lontano dall’abbattimento di strutture oppressive e nocive. Stanchezza e arrendevolezza sono atteggiamenti più che normali di fronte a questi eventi, a episodi sociali e personali che sembrano sempre dire che non importa quanto si lotti, quanto ci si impegni, quanto si ascolti e si cerchi di capire, le cose sono destinate a non cambiare mai.
Discutere con persone che pensano che la questione palestinese – per citare un evento attuale a livello mediatico – non sia affar loro (o addirittura con chi appoggia la politica di Israele), con chi dice che “non si può più dire niente”, con chi difende il diritto alla satira sempre e solo su chi è oppressə e mai su chi opprime, con chi crede di poter esprimere la propria opinione su qualsiasi cosa “perché ne ha il diritto” senza però mai ascoltare, indagare, farsi domande, è una parte della lotta, ma non è un passaggio obbligatorio. Se le persone non sono disposte ad aprirsi, a mettersi in discussione e ad affrontare un cambiamento, allora cercare di mostrare loro un altro punto di vista significa solamente perdere energie. Sembra assurdo dover ancora urlare fino a perdere la voce per chiedere di riconoscere il proprio diritto a esistere, a vivere, a fare ciò che si vuole fare, a essere vistз e ascoltatз e valorizzatз; eppure non lo è.
Per esempio, consigliare a prescindere alle persone queer di fare coming out (o fare outing per loro) – perché ci sembra una cosa giusta e importante – non tiene conto del loro contesto di vita e della loro libertà personale, e anche di quanto possano essere stanche di dover dare spiegazioni ogni giorno a chiunque. Cercare di far parlare della propria esperienza di razzismo le persone nere non solo dimostra l’ignoranza e la mancanza della volontà di informarsi sulle condizioni sociali della comunità nera del nostro paese e sugli episodi quotidiani di violenza, ma anche il pensiero che le persone oppresse abbiano il perenne compito di educare, essere attiviste e lottare, vedendosi tolto il diritto a non esserlo (o anche a non voler esserlo sempre). Fare domande “per semplice curiosità” a persone transgender, chiedendo informazioni che sono facilmente reperibili con una semplice ricerca, evidenzia una carenza nel cercare di comprendere l’altrǝ e le condizioni della sua esistenza. Gli esempi, poi, possono essere infiniti.
In generale, ridurre una persona alla sua esperienza, alla sua caratteristica queer e/o alla sua oppressione è un atto discriminatorio e – per questo – stancante, soprattutto quando va ad aggiungersi a tutto ciò che si è costrettз ad ascoltare e subire ogni giorno. Leggendo anche solo i titoli dei media italiani (nemmeno così tanto diversi da quelli esteri) – dei quali non vogliamo fare né esempi né nomi – e ascoltando l’opinione pubblica frutto del patriarcato, del razzismo e del capitalismo più sfrenato, come può sentirsi unə survivor, che non ha denunciato, che l’ha fatto o che l’avrebbe voluto fare? Come può sentirsi quando tuttз alleggeriscono la situazione e/o lə colpevolizzano? In una società allo e amatonormata, come può sentirsi una persona nello spettro aroace e/o non-monogama nel crescere e vivere con chi dà e ha sempre dato per scontati questi concetti? In una società abilista, che guarda alle persone con disabilità solo con uno sguardo pietista (considerandole angeli o esempi di vita che ci fanno sentire fortunat3 e ci fanno rivalutare i nostri problemi), come può sentirsi chi viene consideratǝ solamente come una spinta a rivedere il proprio stile di vita e non come una persona in sé? Questo discorso – inoltre – è facilmente adattabile anche al fenomeno del “white saviorism”, per cui le persone bianche soprattutto occidentali credono di essere moralmente e civilmente superiori, per questo in dovere di esportare la propria cultura presso le popolazioni considerate “incivili” dallo sguardo eurocentrico.
La stanchezza, dunque, è una delle conseguenze emozionali maggiori a cui il vivere in questa società può portare, in quanto frutto di tutte le oppressioni, incomprensioni, mancanze di una comunità etero-allo-amato-normata, abilista, grassofobica, razzista, patriarcale e sessista. Prendersi una pausa dalla lotta, allentare la presa di una corda che stringe ogni giorno di più, sentirsi spossatз e deboli dopo aver fatto di tutto per venire ascoltatз, sono cose assolutamente normali che devono essere viste come tali. Ovviamente, la stanchezza va valutata nel contesto e a seconda delle situazioni personali – non si parla di stanchezza dunque legata a patologie – ma, in generale, è una sensazione che va rivista e, soprattutto, accettata. Non si è meno attivistз se si è stanchз.
Beatrice